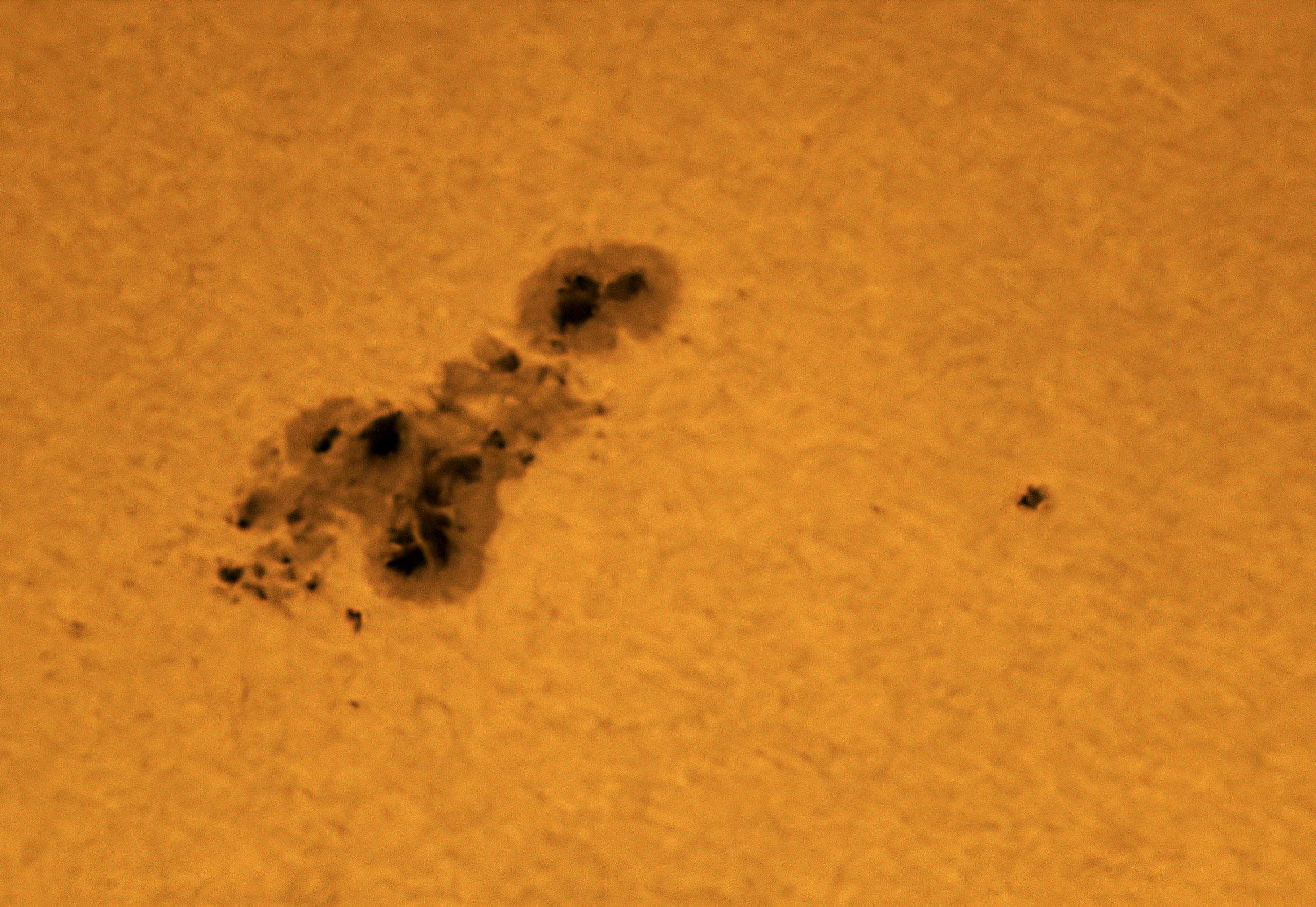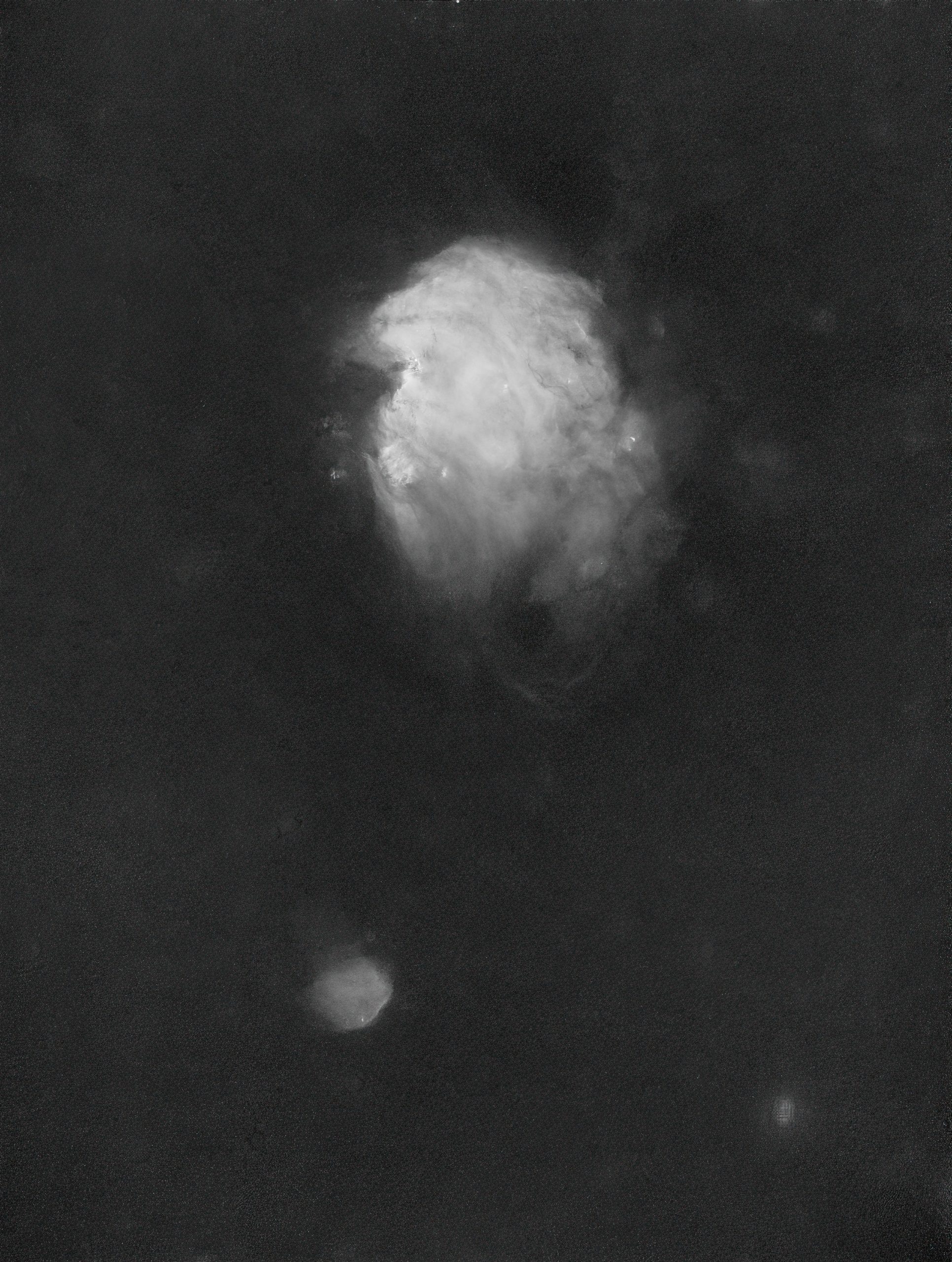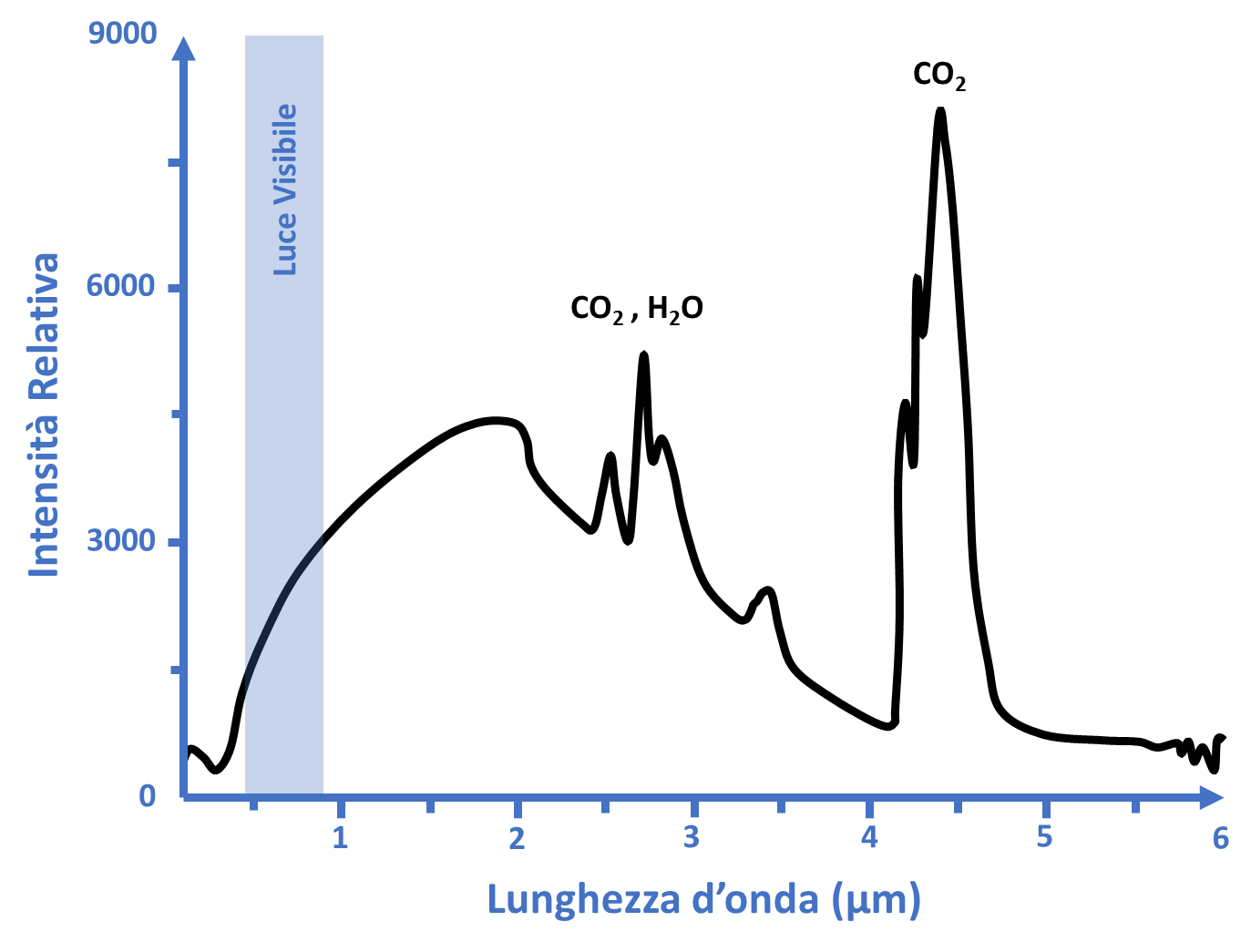Dieci anni con ASTROtrezzi
Finalmente il giorno tanto atteso: il decimo compleanno di ASTROtrezzi. Un’idea, trasformata in un sito internet ed infine in un progetto diventato oggi punto di riferimento per molti appassionati di Astronomia e non solo.
Nato dalla necessità di archiviare e conservare gli scatti astronomici digitali (che sicuramente avrei perso altrimenti), il sito www.astrotrezzi.it si è arricchito negli anni di appunti, articoli, approfondimenti ed eventi. Il tutto scritto (più o meno) in italiano perché è con la lingua madre che si apprendono i concetti più complessi oltre ad essere, per alcuni, l’unica lingua a disposizione. Gli approfondimenti che trovate sul sito internet derivano da una lettura attenta e critica di articoli scientifici in lingua inglese rielaborati poi in italiano.
Malgrado questo, la richiesta arrivata da alcuni amici stranieri di tradurre il sito internet in inglese, ha fatto nascere nel 2017 la pagina Facebook ASTROtrezzi international oltre ad una traduzione dei dati tecnici delle immagini in inglese. Proprio parlando di social network ricordiamo come ASTROtrezzi è stato presente fin dal principio su Facebook, Instagram e Twitter. A causa dell’utilizzo di pochi caratteri, Twitter non ha mai giocato un ruolo chiave ed è sempre stato utilizzato come eco di Facebook.
Il canale Youtube di ASTROtrezzi, attivo dal 2014, è invece utilizzato molto raramente ed è previsto un maggior utilizzo nei prossimi anni.
In questi dieci anni i progetti collegati ad ASTROtrezzi hanno assunto sempre un carattere inizialmente provvisorio per poi diventare definitivo solo dopo una risposta positiva del nostro pubblico. Un esempio di progetti andati a buon fine sono il concorso astrofotografico che si tiene praticamente ogni anno e che ha visto partecipare le/i migliori astrofotografe/i di questo paese. Altri progetti che sono ancora attivi sono: gli speciali, il podcast “ASTROtrezzi in viaggio nel Cosmo” con il sito annesso https://divulgazione.astrotrezzi.it/ e la sezione dedicata allo sviluppo software, ASTROsoftware, all’indirizzo https://software.astrotrezzi.it/ .
Progetti che invece non sono più attivi sono le “serate allo Smeraldino” (2015), il progetto #LUNA19 (2019) dedicato al nostro satellite naturale, il progetto catalogo Messier, One Year of the Sun e le pagine Flickr e Google+.
Anche la newsletter è praticamente non più attiva da qualche anno. Iscritti fin dal primo anno al sito di fotografia Juza e vinti tre Editor’s Pick, nel 2016 abbiamo abbandonato il forum per motivi etici. Sporadiche partecipazioni ci sono state sul forum Astrofili.org e su AstroBin fintanto che il servizio non è diventato a pagamento.
I corsi di astrofotografia presenti sul sito si sono trasformati negli anni da attivi a passivi. Invece, in collaborazione con ARTESKY, sono nati i corsi di Astronomia dal vivo. Decine di “studenti” sono passati da questi corsi ed alcuni di loro sono diventati amici e/o astrofotografi professionisti.
Non ha mai preso il via invece la sezione del sito dedicato agli appassionati di astronomia del Ticino (ASTROtrezzi&CH) o alle donne. Fortunatamente, in questo ultimo caso, è nato il gruppo “Astrofile” che sta avendo sempre più successo e che ASTROtrezzi supporta e consiglia a tutti i suoi lettori e lettrici.
I visitatori del nostro sito sono aumentati negli anni ed ora si aggirano intorno al centinaio al giorno, provenendo principalmente dall’Italia oltre che dall’estero (Germania, USA, Cina, Russia e UK). I post e le pagine pubblicate in questi dieci anni sono 793. La pagina Facebook di ASTROtrezzi ha 1548 mi piace (1595 follower) mentre la versione international 148 mi piace (156 follower). La pagina Instagram invece è seguita da ben 534 persone.
Ovviamente non staremo qui ad elencare i successi di ASTROtrezzi in questi dieci anni di vita: dai premi vinti (tra cui lo Star of Europe Awards 2015), agli articoli di settore dedicati ad astrotrezzi, ai libri, alle immagini pubblicate su riviste, sui calendari o presentati a mostre di astrofotografia nonché alle decine di amicizie nate dallo scambio di e-mail con voi lettori. Per non parlare della collaborazione con riviste scientifiche, delle serate osservative e delle numerosissime conferenze tenute tra le province di Milano, Monza e Brianza, Como e Lecco. Proprio in questa ultima mi ci sono trasferito nel 2017.
Tra le collaborazioni più importanti, oltre alla già citata ARTESKY abbiamo quella con il Gruppo Amici del Cielo e con il gruppo Enjoy Briosco.
Il trasferimento da Briosco (MB) a Varenna (LC), l’abbandono della carriera universitaria per una in azienda oltre alla pandemia di Covid19 ha rallentato il consolidato sviluppo di ASTROtrezzi. Sintomo di questa crisi è ad esempio il numero di conferenze tenute nel biennio 2020-2021 ridotte al numero di quattro.
Per fortuna il 2022 è iniziato sotto i migliori auspici con 11 eventi già svolti e 2 pianificati per il solo mese di giugno. Sono stati pubblicati 16 post di immagini e articoli dedicati all’inquinamento luminoso. Dal 2022 è nato anche il progetto Lario Celeste ( https://www.larioceleste.it/ ) che, riprendendo il progetto ASTROAlps del 2017, si propone di formare una community di astrofili residenti nei comuni del Lario Orientale. Inoltre è prevista la partecipazione attiva sul territorio con una serie di conferenze, mostre e osservazioni pubbliche. Ultima ma non meno importante è la lotta all’inquinamento luminoso che si opera attraverso il monitoraggio della brillanza del cielo notturno (misure di SQM) e segnalazione degli impianti non a norma.
COSA FAREMO
Cosa ci aspetta in questo 2022? La maggior parte delle nostre energie andranno a supporto del progetto Lario Celeste che sta muovendo i suoi primi passi malgrado le gravi difficoltà incontrate nel contattare i comuni lariani. Fortunatamente si sono dimostrate più attive e all’altezza le numerose associazioni culturali presenti sul territorio con cui stiamo iniziando alcune collaborazioni.
Il 2022 sarà anche l’anno in cui inizieranno le riprese di un docufilm (Gybe Studio) che ci vedrà protagonisti di un racconto di vita vissuta con e per l’Astronomia.
Ovviamente continueremo a collaborare con il Gruppo Amici del Cielo e con ARTESKY con conferenze e corsi tenuti prevalentemente in Brianza.
Infine è in atto una ricerca bibliografica sulla storia dell’illuminazione pubblica a Varenna e nel Lecchese nell’ambito dello studio dell’inquinamento luminoso e della sua evoluzione nel tempo.
Oltre a ringraziare tutti voi per la forza e gli stimoli che mi date per proseguire in questo progetto, volevo ricordarvi che nel 2022 si terrà una serata speciale allo Smeraldino (seguiteci alla pagina ASTROeventi del sito) in cui festeggeremo il nostro decimo compleanno in compagnia del mitico Newton da 250 mm di diametro e, perché no, di un simpatico amichetto anfibio. A presto e cieli sereni a tutti!!!